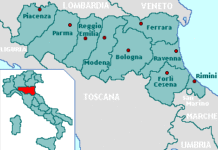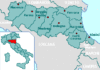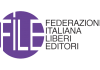I "no" ripetuti alle richieste di Lombardia e Veneto di regionalizzare i ruoli degli insegnanti hanno incendiato il dibattito sull’autonomia differenziata che da molte settimane si stava paralizzando in una serie infinita di vertici di governo. Dopo gli scambi di accuse del fine settimana fra i presidenti di Lombardia e Veneto e il premier Conte, l’autonomia si è insediata al centro di una scena già occupata da tante incognite sulla sopravvivenza del governo.
Ma di che cosa si discute davvero? Di soldi, prima di tutto. Le richieste di Lombardia e Veneto, molto più di quelle avanzate dall'Emilia Romagna, hanno scatenato le polemiche sulla distribuzione delle risorse finanziarie fra le Regioni. Gli oppositori dell’autonomia gridano a una sorta di secessione ombra da parte delle Regioni più ricche, desiderose di tenersi il proprio gettito fiscale negando i contributi ai territori più poveri, i tifosi della riforma puntano invece su un dividendo dell’efficienza dalla regionalizzazione. Una (molto eventuale) attuazione dell’autonomia differenziata potrebbe far evaporare sia le paure degli oppositori sia le speranze dei promotori della riforma.
In prima applicazione, il trasferimento delle competenze avverrebbe attribuendo alle regioni la stessa spesa che lo Stato oggi effettua sul loro territorio, senza quindi cambiare di una virgola la distribuzione dei fondi pubblici. Per ogni competenza, l’assegno da staccare sarebbe deciso in base all’analisi della spesa statale regionalizzata: se lo Stato spende 1.000 per la valorizzazione dei beni culturali in Lombardia, per esempio, e la competenza viene assegnata alla Regione, si dovrebbe attribuire al governo territoriale una compartecipazione di 1.000, esattamente pari alla spesa statale.
Nelle altre Regioni, quindi, non cambierebbe nulla. Lombardia e Veneto, e in misura minore l’Emilia Romagna, promettono di gestire le funzioni oggi statali in modo più efficiente, spendendo meno rispetto al governo centrale. Ma questa, al momento, è una petizione di principio, difficile da dimostrare e soprattutto difficile da attuare in tanti settori dove la spesa è rigida, perché legata in modo predominante agli stipendi del personale che sono determinati dalla contrattazione nazionale.
Lombardia e Veneto, in altre parole, non potrebbero certo ridurre la spesa per gli insegnanti, nemmeno con la regionalizzazione dei ruoli a cui il presidente del Consiglio e il Movimento 5 Stelle si sono opposti. Il quadro cambierebbe con l’applicazione dei costi standard, cioè di una serie di indicatori che dovrebbero individuare il "prezzo giusto" dei servizi sulla base di parametri legati alle caratteristiche demografiche, sociali e territoriali di ogni area del Paese. Perché è ovvio, per esempio, che i costi di alcuni servizi di welfare crescano dove la popolazione è più anziana, oppure che la spesa per le infrastrutture cambi se il territorio è pianeggiante oppure montano.
La teoria è semplice, la pratica complicatissima. Prima di stabilire la spesa efficiente bisognerebbe individuare anche i livelli essenziali dei singoli servizi, cioè le attività che la pubblica amministrazione deve garantire ai cittadini. Scelte del genere richiedono un elevatissimo approfondimento tecnico e soprattutto una forte condivisione politica. Entrambi i presupposti sono mancati in questi anni, tanto è vero che con la parziale eccezione di Comuni e Università costi e fabbisogni standard sono rimasti confinati nella teoria da convegni. Nonostante siano previsti per legge da dieci anni esatti. A prescindere dall'autonomia differenziata.
REDAZIONE CENTRALE