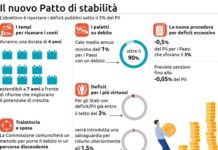di James Hansen
Visto il proseguire dell’isterismo elettorale americano, forse è bene ricordare che astiose controversie riguardo al modo di contare i voti in seguito a elezioni presidenziali vigorosamente contese—e le conseguenti difficoltà nel processo di trasferimento dei poteri al “President-elect”—sono tutt’altro che una novità negli Stati Uniti.
Non occorre neanche andare troppo lontano nel tempo per trovare un caso, tra l'altro con dei risvolti particolarmente esilaranti. Si tratta delle presidenziali del 2000, decise sul filo di lana e sulla base di una manciata di voti dello Stato della Florida, accumulando tra conteggi e ri-conteggi un ritardo di 36 giorni.
I Democratici, entrati nella campagna per sostituire il Presidente Bill Clinton—molto popolare ma non più eleggibile alla Presidenza dopo aver compiuto i due mandati di quattro anni—erano perfettamente convinti di massacrare il candidato repubblicano, George W. Bush. Del resto, proprio Clinton aveva già battuto Bush padre—George anche lui—alle presidenziali del novembre 1992. Al figlio George W si opponeva Al Gore, pure lui discendente di un’importante dinastia politica americana. Ad aggiungere confusione a una situazione già contorta fu la concessione della vittoria inizialmente fatta da Gore a George W e poi rimangiata quando i vari ri-conteggi parevano tendere a limare il vantaggio del candidato repubblicano.
Finalmente, dopo cinque settimane, la Corte Suprema decise di fischiare la fine alla partita. Bush figlio fu riconosciuto Presidente per uno scarto di poche centinaia di voti. Al Gore invece si fece crescere la barba e si dette all’attivismo climatico. Ad ogni modo, a quel punto si doveva arrivare al “turnover”, con l’inaugurazione della nuova Presidenza e il passaggio materiale della Casa Bianca all’odiato nemico. Il team di Clinton—composto da grandi sostenitori di Gore, che era stato il vice del loro Presidente— pensava di dare a Bush il benvenuto che, secondo loro, meritava.
Quando i “nuovi” si presentarono, trovarono scritte oscene sui muri, le etichette con i numeri sistematicamente tolte dai telefoni e le tastiere di un centinaio di computer a cui era stata rimossa la lettera “W” che sarebbe servita per scrivere il nome di George “W” Bush. Secondo una relazione riguardo ai danni fatta in seguito dal GAO-General Accounting Office—una sorta di revisore interno del Governo federale americano—scomparirono una manciata di stemmi presidenziali e perfino i pomelli di parecchie porte. In altri casi, chiavi furono inserite nelle serrature degli armadi blindati e poi spezzate, di modo che non si potessero aprire, come anche cassetti di scrivanie chiusi con la colla.
Quello che il GAO non diceva—almeno per iscritto—era che in alcuni uffici qualcuno aveva perfino defecato negli angoli o orinato sui muri. Sono episodi conteggiati nella relazione ufficiale sotto la voce “cattivi odori”, come anche quelli rilasciati dai bidoni di spazzatura riversati nei corridoi.
Joe Biden è—o almeno presto sarà—il nuovo Presidente degli Stati Uniti. All’epoca di George W, la leadership democratica parlò di “pranks”, di innocui scherzi studenteschi, per spiegare l’accaduto. Era comunque il pensiero che contava. I danni fisici, almeno quelli tracciabili attraverso la fatturazione per sostituire le apparecchiature danneggiate, arrivavano a malapena a 15mila dollari. Forse questa volta toccherà ai Repubblicani spiegare una scherzosa “escrezione” in mezzo alla scrivania dell’Ufficio Ovale...