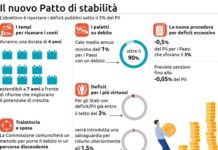DI MARCO FERRARI
Non c’è dubbio che il rapporto tra Eugenio Montale e le Cinque Terre sia stato importantissimo e problematico allo stesso tempo. Qui a Monterosso è ancora depositato il pozzo creativo del Premio Nobel 1975, una sensazione poetica che si respira tra la sua casa di Fegina, la macchia mediterranea, gli scogli a strapiombo sul mare, la suggestione delle terrazze tra cielo e onde. Non a caso il Parco Letterario “Eugenio Montale” è nato in occasione dei 40 anni dal Nobel per la letteratura al poeta per fare rivivere al visitatore le emozioni intense che il poeta è riuscito a imprimere attraverso i versi delle sue liriche. Monterosso ha ricordato, con una recita dell’attrice Lella Costa, il quarantennale della scomparsa di Eugenio Montale, nato a Genova nel 1896 e deceduto la sera del 12 settembre 1981 a Milano. Peraltro, il tema della morte è presente in molte sue opere sia in forma esplicita che implicita, ed è spesso legato all'esposizione di idee filosofiche ed escatologiche, come testimoniato da una delle sue poesie più note, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.
A Monterosso, nella zona di Fegina si trova quella che lui chiamava “la pagoda giallognola” o “la casa delle due palme” costruita nel 1880. Si volta lungo via IV Novembre e si risale un poco a sinistra ed eccoci in viale privato Domenico Montale. Quello in alto è il covo della poesia novecentesca. Villa Montale oggi è un normale condominio, mezzo vuoto d’inverno e pieno d’estate, non visitabile per gli esterni. Le due palme sbilenche che stanno davanti alla villa furono piantate nell’anno di grazia 1900, poi una crebbe più dell’altra e separarono per sempre le loro altezze, ma non il loro destino congiunto. Certo, ora c’è un bosco di palme sulla destra che oscura la loro simbolica rilevanza, ma questa scorza un po’ consunta del fusto dovremmo considerarla come la patina ansimante che copre il mondo oramai perduto di Ossi di seppia. Eppure, pare ancora che sia rimasto nell’aria l’eco del corno di mare che il fratello del poeta suonava come una bucina per i pranzi di famiglia, richiamando i distratti commensali. Molte cose si sono perdute per sempre, come la panoplia delle lance e delle frecce che era appesa alla sala da pranzo, a pianoterra.
Lui stesso aveva beffeggiato i cambiamenti avvenuti dentro e fuori la villa delle due palme, oramai circondata da palazzi, torrette, bungalow, villette con i nani appesi al muro e stabilimenti balneari muniti di altoparlanti, sedie a sdraio e ombrelloni sponsorizzati. Niente a che fare con il paesaggio del Nostro Sommo Poeta simbolicamente identificato nei «cimelli» di canne e greppi, greti e petraie, botri e muretti a secco, orti e pendii, «volute aride dei crepacci» su cui fioriscono
eucalipti e agavi, carrubi e sambuchi, pitosfori e pini nani, dove posano il becco galletti di marzo e folaghe, merli acquaioli e balestrucci.
Montale e stato il primo vero camminatore delle Cinque Terre, l’anticipatore del trekking. Lo racconta Piero Gadda Conti, cugino del più noto Carlo Emilio, che aveva casa al Castello di Levanto, altro cenacolo intellettuale dove si ritrovavano Riccardo Bacchelli, Alessandro Bonsanti, Arturo Loria, Giacomo Debenedetti, Carlo Linati, il direttore di «Solaria» Alberto Carocci, il direttore di «La Fiera Letteraria» Giovanni Battista Angioletti. E poi un dimenticato Leo Ferrero, scrittore e drammaturgo, costretto all’esilio dal fascismo e morto in un misterioso incidente stradale il 26 agosto 1933 a Santa Fe nel New Mexico.
In una memorabile estate del 1926 Montale, Gadda e Linati compirono la traversata da Levanto a Portovenere, quello che oggi e indicato come sentiero costiero delle Cinque Terre, anche se la Via dell’Amore non esisteva ancora.
Montale si trovava talmente bene in quei sentieri che, camminando, era solito cantare il suo vasto repertorio melodrammatico. Sì, voleva fare il cantante lirico e, se non ci fosse stata la Prima guerra mondiale a troncare i suoi studi, forse ce l’avrebbe fatta.
Esiste pure una mappa tracciata a penna da Montale con i sentieri che portavano a Soviore o a Montereggio o a Montenero per godere la visione di Portovenere, a cui è dedicata una sua nota lirica.
Ma il suo regno escursionistico era il Mesco, la mulattiera del Semaforo, le cave, le pinete, le scalinate di pietra tra i vitigni bassi da cui nasce lo sciacchetrà, il viso dei papi. Il bello è che neppure in queste canicolari passeggiate, Montale rinunciava al suo completo scuro. Non ci sono fotografie che lo ritraggono in maglietta balneare o costume da bagno. E poi, dopo la camminata, lui che soffriva d’insonnia, faceva il riposo nella casa delle due palme in quella atmosfera di un pomeriggio caldo e afoso, come spiega nella poesia “Meriggiare pallido e assorto”.
Di questa bella casa, costruita all’inizio del Novecento e divisa tra quindici eredi, alla fine gli apparteneva un quinto dei due terzi. Un amaro calcolo ereditario.
«Cercherò di non passare più sulla linea Genova-Spezia», scrisse Eugenio Montale alla madre nel 1954, parlando di quella ferrovia dove, tra una galleria e l’altra, appariva al viaggiatore la «pagoda» giallognola e un po’ stinta. Ma poi,
villa dopo villa, non si vedeva più. Attorno alle proprietà dei Montale – l’edificio dei cugini Domingo, padre di Eugenio e Domenico, e quello dell’altro Montale, lo zio Laurent, botanico appassionato, maniaco delle piante grasse –, pian piano
è montata una giungla di cemento e asfalto, prima le ville di emigrati di ritorno, «le architetture di marzapane degli arricchiti», quindi le case dei milanesi, gli alberghi e i ristoranti con le vetrate.
L’incanto naturale dei tempi passati, sommato al dono irripetibile della giovinezza, ha tolto al poeta il suo nido creativo. Laggiù dove esisteva una baia sassosa e solitaria, era comparso il mitico Gigante, ora in restauro. Quando nel 1910 Arrigo Minerbi, noto scultore di origine ebraica, lo liberò dalle impalcature, era alta 14 metri, pesava 1700 quintali e oltre al tridente reggeva una conchiglia sul capo, che non era altro che una originale terrazza della villa, simbolo di ricchezza di una famiglia rientrata dall’Argentina.
L’edificio apparteneva all’avvocato Giovanni Pastine, un emigrato ligure che agli inizi del XX secolo ritorno a Monterosso tanto ricco da poter costruire, in quello
che allora era un minuscolo villaggio, un palazzo «degno di Semiramide», al posto della oramai mitica casa dei doganieri. Montale ricorda i coniugi Pastine nelle pagine de La Farfalla di Dinard, chiamandoli con i nomi di don Pedro e donna Juanita.
La villa dell’architetto Levacher fu pesantemente bombardata durante la Seconda guerra mondiale e ulteriormente indebolita da una mareggiata il decennio successivo. Ora e sopravvissuta solo la torre che svetta sulla collina. Della splendida scalinata in marmo, del porticato e della terrazza sul mare non è rimasto quasi nulla. Oltre la volta scavata nella roccia adesso c’è il circolo velico, assieme ai fantasmi irrequieti dei Pastine, tanos di ritorno e sua moglie. Gli occhi indiscreti di un ragazzo guardavano quella ricca signora, donna Juanita e le sue “cocorite”, la villa e un edificio a strapiombo sul mare che era, appunto, “La casa dei doganieri”, come è intitolata una sua poesia.
Montale era preso da sgomento le volte che tornava per un funerale. Oramai il pozzo della memoria era chiuso nella cappella di famiglia, lassù al cimitero dei Cappuccini, dove riposano i genitori e i fratelli. Lui no, non volle essere seppellito qui, ma a San Felice a Ema, sulle colline di Firenze, città che lo accolse dal 1927 al 1948. Ma diciamo la verità, non gli è andata tanto bene, perché quella zona di Firenze è stata invasa anch’essa dal cemento. La concessione per il loculo è scaduta nel 2011, trent'anni dopo la morte avvenuta nel 1981, e il nome di Eugenio Montale ancora dopo dieci anni compare nella lista delle concessioni scadute, sia on line che sulla bacheca del cimitero di San Felice a Ema. Era una cosa che poteva essere evitata, trattandosi di un Premio Nobel che rischiava di finire in una fossa comune. Ma l'importante è che sia stata trovata una soluzione definitiva, perché se anche la concessione è rinnovata, tra 30 0 40 anni il problema si riproporrebbe. Così il Comune di Firenze si è impegnato perché le spoglie di Montale continuino ad essere conservate nel loculo che custodisce anche le spoglie della moglie. Bene ha fatto il sindaco di Monterosso a dare la disponibilità a traslare qui i resti del poeta ligure, dopo riposa il resto della famiglia.
Molto è cambiato pure nella sua casa dove adesso le palme svettano confusamente oltre il terzo piano. Solo un paio di pini e altre piante resistono, la vigna e diventata parcheggio, il fossato erboso e trafficato, la spalliera dei limoni e il muro di un ristorante. E il pozzo dell’orto? La vasca delle ninfee? E gli «erbosi fossi»? La vaschetta circolare con al centro un pesce con la bocca aperta, da cui sale un misero zampillo, era la vasca delle ninfee in cui Montale cadde a capofitto rischiando di annegare. La fioritura del giardino è ora sostituita da un prato all’inglese e la vigna e stata tagliata. Ci sono dei poggioli laterali sull’edificio, non c’è più il terrazzo al terzo piano. Sul lato nord una lapide ci rammenta cos’era la casa delle due palme. Ci saranno ancora delle lucertole, rammentante nella poesia “Irene”? Montale, in seguito, avrebbe considerato la vita come un bestiario: chiamò Volpe e Mosca le figure femminili a lui più vicine, ebbe un forte legame con il «cagnuolo rossiccio» Galiffa, infilo anguille dappertutto, citò nelle liriche farfalle, cavalli, mortole, porcellini d’India, pipistrelli, cani, gatti, tortore, grilli, vermi, topi, animali che servono a riattizzare reminiscenze famigliari. La pagoda delle due palme esattamente come la collina di San Giovanni e Villa Meridiana di Italo Calvino a Sanremo, come il paesaggio dell’estrosa fanciullezza di Camillo Sbarbaro a Santa Margherita Ligure o l’incanto collinare di Giorgio Caproni, sono pesi d’incerta memoria. Eppure, molto di quel paesaggio verticale resiste, come l’ascensore di Castelletto cantato da Giorgio Caproni: «Quando mi sarò deciso / d’andarci, in paradiso / ci andrò con l’ascensore / di Castelletto, nelle ore / notturne, rubando un poco / di tempo al mio riposo». I paesaggi verticali e gli amori in salita cantati da Giorgio Caproni ed Eugenio Montale, disegnati dalle parabole musicali di Gino Paoli, Umberto Bindi, Bruno Lauzi e Ivano Fossati, il dialetto esaltato da Fabrizio De André sono il cuore e l’anima della Liguria mediterranea. Un paesaggio, quello incastonato in queste colline marine, dove erano depositati i sogni giovanili di Montale velati per sempre da uno spasmo di pessimismo. Qui ha impiantato il paesaggio metafisico della lirica italiana, tra agavi e pini, come Caproni lo ha inquadrato nella regione delle colline aride e torrentizie.
Così la poesia di Montale resta radicata a questo impervio e arso terreno delle Cinque
Terre, a questa natura «scabra ed essenziale» con un mare «fioccoso e pulsante», che va da Levanto a Portovenere, dove aveva consumato la sua «rustica adolescenza levantina». Un orto da cui fuggire e in cui depositare per sempre il rovello della nostalgia per il tempo che passa e inghiotte tutto, in cui non sarebbe stato
più possibile ritrovare «la gloria del disteso mezzogiorno». Dalla spiaggia del Gigante ancora adesso osserviamo come tasti di pianoforte gli altri paesi:
Vernazza, l’alta Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Per ognuno di loro c’è una storia di presenze e assenze. Il paesaggio delle Cinque Terre, così unico e particolare, dove i poderosi terrazzamenti sembrano buttarsi a picco sul mare, diventa quindi “culturale” e “letterario” nella consapevolezza di una bellezza mantenuta nei sentieri, nelle spiagge invernali, nel borgo di Monterosso, che diventa un percorso naturalistico dove la letteratura si mescola alla storia del paese. Nel suo centro storico, per i sentieri secolari che lo abbracciano, tra vigneti, orti e uliveti aggrappati ai terrazzamenti, fatti di muretti a secco, a picco sul mare, a ogni passo il turista letterario percepisce nell’aria la poesia di Montale.
Basti pensare ai versi di “Meriggiare pallido e assorto”, “I Limoni”, “La casa dei Doganieri”, “La Punta del Mesco”, “La farlalla di Dinard” per capire la relazione ancestrale tra Montale e il paesaggio delle Cinque Terre rintracciare ora nei sentieri, come quello ad anello che da Villa Pastine, accanto al Gigante, sale in collina tra la vegetazione fino ad arrivare a quella che fu Villa Montale oppure il tracciato che da Fegina arriva a Sant’Antonio del Mesco oppure seguire la strada delle limonaie. Percorsi che, nel turismo di massa di oggi, tanta gente cerca ancora sperando di ritrovare l’anima del Premio Nobel.