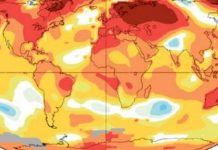Nella cattedrale sprofondata nei vicoli, i famosi “caruggi”, intitolata a San Lorenzo, con quella bomba inesplosa inglese della II Guerra mondiale, caduta nel terribile bombardamento navale dell’8 febbraio 1941, conservata bella intera, e perfino lucidata, nella navata di sinistra come la prova di un miracolo, si celebra l’elegia della “città ideale”, uscita dalla tragedia del ponte.
Il ponte maledetto. Officiano sull’altar maggiore, dietro un tavolo damascato di rosso, il professor Lorenzo Ornaghi, già rettore della Cattolica, Giuliano Ferrara, il giornalista dalla fervida carriera, fondatore de “Il Foglio”, ex dirigente comunista, ex ministro di Berlusconi, testa pensante dei tempi moderni e introduce padre Mauro De Gioia, una delle “anime culturali” che cercano di agitare il dibattito genovese nella chiesa .
“La città ideale e una riflessione su Genova”, dice il titolo della discussione nel programma, sempre raffinato di “Cattedrale aperta”, l’iniziativa che il cardinale Bagnasco organizza con raffinatezza, ma anche una precisa determinazione nel suo magistero di pastore in questa città. E pensare che questa idea di “riflettere” su Genova con il parametro “storico” della città ideale, dell’Utopia di Tommaso Moro, era venuto al cardinale arcivescovo, giunto oramai al suo ultimo anno da arcivescovo di questa martoriata città, un mese prima della tragedia del ponte, quando l’emergenza che ha cambiato tutto neppure era immaginabile.
E’ cambiato tutto, ma forse è venuta fuori un’altra città, prima “spezzata” da quella tragedia, con i muri che si alzano nelle sue comunicazioni, lo strappo verso un isolamento caotico, non solo con il mondo, ma con essa stessa, una parte di città di qua e l’altra di là, irraggiungibili tra loro e poi la reazione, la coesione sociale per uscire da un taglio così netto, da un crollo tanto rovinoso.
Martedì 5 febbraio 2019, 150 giorni dopo, in una sera d’inverno di clima rigido e ombre buie intorno a quella cattedrale piena di capolavori e di una soffusa mestizia, parlare di città ideale e riflettere su questo tempo genovese così sospeso è un po’ come raccogliere quasi una provocazione, perché il dolore della città lo senti quasi nelle ombre lunghe davanti a san Lorenzo, nel viavai rarefatto del freddo dei passanti nella la strada che si tuffa verso la scalinata della cattedrale, i leoni di marmo che scortano i portali aperti per un pubblico di intellighentia cattolica, di studiosi, ma anche di fedeli diligenti, che entra nelle navate, si va a sedere sui banchi, davanti a quel tavolo damascato dove prendono posto i due relatori, mentre il cardinale assiste dalla sua cattedra con il tricorno ben calzato.
C’è anche il sindaco di questa città, Marco Bucci, in prima fila, forse a chiedersi come un grande professore, un vero moralista di formazione cattolica e un giornalista di vaglio, ma anche di nota vis polemica, le cui punte acuminate di scrittura non hanno smesso di colpire anche dopo che ha lasciato la direzione del “Il Foglio” per diventarne un quasi quotidiano editorialista, entreranno nelle mura genovesi. Come la scopriranno, questa Genova nuova e dolorante e ne tracceranno un ritratto comunque diverso, anche ai suoi occhi di primo cittadino ed ora anche di supercommissario a quel ponte da ricostruire, in tutti i sensi.
Una città ideale. Un’utopia? Genova che ci azzecca con quella definizione da esperti filosofi, non certo da sociologi di questo tempo moderno. Come proiettarla la Genova del dopo ponte, ma anche la Genova dell’anno 2019 appena cominciato, su questo schermo così mobile, dalla prospettiva del ponte oramai circondato di gru, di uomini attrezzati, pronti a smontarlo, a farlo esplodere in una cascata di macerie, a calarlo giù, a “svuotare” il cielo della Valpolcevera? Come proporre questa prospettiva al resto della città, che da ogni angolo guarda qua, chiedendosi ancora, 150 giorni dopo, se questo è il declino o è la speranza, se questa è la fine o un Rinascimento?
Il porto che perde traffici, il turismo che perde visitatori, gli uomini d’affari che perdono la speranza, le aziende che perdono posti di lavoro, le botteghe che perdono clienti, le strade interrotte che si svuotano nella mancanza di traffico, perfino il cielo che sembra perdere colore nello strappo di quel maledetto 14 agosto del diluvio….
Ornaghi racconta con molte citazioni il tratto della città ideale, lui si che se ne intende per la sua scienza, oggi di direttore della Biblioteca Ambrosiana, ieri di Rettore per oltre 12 anni della Università Cattolica ed anche per essere stato ministro dei Beni culturali nel governo Monti. Cita ovviamente Moro dell’Utopia, ma anche Kant, per concludere che una città ideale non è mai stata realizzata, tanto meno la Città del Soile o l’urbs o la civitas romane. Parla, Ornaghi, anche dei tempi di oggi, dello spaesamento, della rassegnazione, dell’impotenza, in attesa che la politica cambi. Come inserire in questo il progetto di un luogo ideale, quando quella politica è invasiva e pervasiva, quando chiediamo alla politica tutto e otteniamo di rimando solo quello spaesamento che si spiega con il logoramento delle istituzioni, con la sudditanza.
E’ chiaro che una città ideale sottintenderebbe un buon governo mentre , come diceva Napoleone “il fato è la politica” e oggi il fato ci regala quello che abbiamo sotto gli occhi.
“La città ideale avrebbe necessità di quelle che sono le virtù teologali, cioè il contrario dei vizi capitali”, sostiene Ornaghi. Come dire che la città ideale è una proiezione quasi impossibile oggi.
Giuliano Ferrara conosce bene Genova per averla frequentata da giornalista e da politico, anche nei tempi aspri delle contrapposizioni tra i portuali, i mitici “camalli” e la città degli anni Ottanta e ha preso allora le misure del luogo. Quindi gli è facile, dopo una specie di introduzione filosofica sulla città ideale, “riscatto dal peccato originale” e sulla definizione di Kant “che non si può raddrizzare il legno storto dell’umanità”, ricordare che la città è in fondo una grande risorsa dell’ organizzazione sociale. “La città è anche come un vessillo di quello che siamo e vorremmo essere”, spiega il giornalista.
Questa cattedrale, così sprofondata nella pancia della città e dei caruggi, gli pare come una vera “chiesa domestica”, come la piazza della città stessa. Poi andiamo alla diagnosi più autentica ed anche positiva che Ferrara elabora per questa Genova, “dove è oggi e come è oggi”.
Una città dove alcuni valori sono rimasti solidi e riaffermati: nel Dopoguerra l’antifascismo, il peso di una propria cultura identitaria, anche attraverso personaggi come il cardinale Giuseppe Siri ed anche il prete politico, don Gianni baget Bozzo.
“Qui lo scetticismo non è più un proverbio, dice Ferrara, ma un metodo sistematico:” E certamente allude alla filosofia del “maniman”, classico intercalare genovese, del quale ha capito la profondità. A questo “status” prettamente genovese si riferiscono anche la capacità dei “giochi finanziari”, che diventano sotto la Lanterna un habitus non certo “ideale”, ma concreto, pragmatico.
Si arriva così alla vicenda del ponte, alla tragedia, al crac, che porta a implicazioni e riflessioni tecniche, politiche culturali, gestionali su come Genova ha reagito.
“Genova ha dimostrato cosa significa tenere su le infrastrutture, quale importanza hanno in una città che è organizzata proprio sulle infrastrutture, non solo il ponte che cade, ma anche il porto collegato con le sue divaricazioni, i tunnel, le gallerie che spuntano ovunque, la Sopraelevata, che “sfreccia nel ventre della città”, sfila davanti ai tesori della Cultura, come il Palazzo Reale. Insomma, questa è la città delle grandi partenze, dei grandi arrivi nel porto e altrove, una città che deve per forza tenere la testa sopra il pelo dell’acqua.
Ecco allora la reazione al ponte che crolla. Tutto questo spinge i non genovesi, i non scettici per genetica, quelli così differenti dai zeneisi, a capire, per esempio, lo spirito degli sfollati del ponte che formano i comitati, che trattano da pari a pari con le autostrade, con i concessionari.
Ferrara mostra ammirazione per il cardinale Bagnasco, non solo perché ha osato organizzare un dibattito come questo e poi di mantenerlo dopo il grande crollo, ma anche perché ha infuso in questa genovesità come “un carburante spirituale” nel momento della sciagura, quando sarebbe stato così facile scaricare.
“Una tragedia è una tragedia, non si può trasformare nel grottesco, sostiene, rendendo merito, Ferrara, che sottolinea come questa resta il luogo del “mugugno”, di tutte le aristocrazie, di quelle operaie, di quelle alto borghesi, perfino di quelle del vecchio calcio italiano che qui vennne fondato. La sostanza è che, cercando sempre quel parametro della città ideale, Genova affronta la curva del nostro vivere come reagente per dire che qui c’è un’anima.”
La compostezza di Bucci, il sindaco, fa notizia, ma fa anche parte di questa “anima”, che potrebbe essere vista anche in una ottica un po’ “nevrastenica”, se si misurano i grandi dolori, l’epopea del mare che si affaccia in modo così forte nella storia e nella geografia genovese, il territorio duro, così tormentato nei suoi saliscendi, nei monti che incombono, nelle discese, nelle salite, nei precipizi e appunto nei ponti, nei tunnel, nelle Sopraelevate. “Qui non c’è la piattezza di altre città, ma piuttosto la straordinaria invenzione della natura, della storia e della geografia, che hanno confermato un territorio alla fine in difesa di questa sua saldezza”.
Come può concludere il cardinale Bagnasco, padrone di casa, una simile discussione, partita dalla dotta introduzione di De Gioia, continuata con la teorizzazione di Ornaghi e culminata nel “canto” di Ferrara, che alla fine vede in Genova non tanto una città “ideale”, ma una città forte, salda, quasi “miracolosa” nella sua reazione all’ ultima tragedia?
Per l’arcivescovo la contrapposizione tra città reale e ideale “è fittizia e dannosa”, perché l’ideale presiede alla vita e la realtà poi è sempre misurata e pesata sull’idea. L’utopia per Bagnasco è molto difficile oggi da affrontare, in tempi nei quali grandi filosofi del tempo moderno, come Zigmund Baumann, teorizzano la Retropia, il volgersi non in avanti, ma indietro. E qui Bagnasco sorprende un po’, tessendo una specie di elogio del ’68, individuato come un tempo nel quale “tra eccessi e speranze” si immagina un futuro nel quale costruire un mondo diverso, nel quale c’è una spinta ideale che consentiva di guardare avanti con grande forza.
Invece le generazioni di oggi guardano a quel futuro con paura, temendo per la loro vita, per il lavoro, basandosi su standard di successi fittizi, angosciandosi, quasi disperandosi. E allora si guarda indietro per recuperare punti fermi, che il futuro non contiene più.
E’ una scena preoccupante nella quale le entità chiave, la famiglia, la scuola, la città stessa sembrano disgregarsi, scivolare via, diventare, sempre seguendo Baumann, liquidi e quindi imprendibili.
A questo punto dove si colloca la città, come ci si può appigliare al suo status oggi? Nessun dubbio per il cardinale dentro alla “cattedrale aperta”: la città è “la casa”, il luogo dove si ha un tetto sulla testa, “dove c’è un abbraccio di relazioni, dove non ci si sente soli…..”.
Bagnasco è perentorio: la malattia più grave di questi tempi non è il cancro, ma la solitudine che spaventa a qualsiasi età, che colpisce soprattutto i giovani e gli anziani. Ecco perché la casa può essere considerata il paradigma della città e ancor più del paese, del continente, del mondo: qui ci si incontra, qui.
Non sfugge a Bagnasco che dopo la tragedia del ponte nella città di Genova si è sprigionato “misteriosamente” un sentore comune, un senso nuovo di appartenenza.
Anche questo ha un significato “miracoloso”, anche se il cardinale non può dirlo, come aveva fatto il laico Ferrara, da oggi genovese di adozione.
(Franco Manzitti)