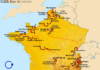Tre ragazzine adescate su Whatsapp e tenute in scacco e ostaggio dell’orco per tre anni. Ragazzine di 11 anni, poco più che bambine che inviavano e ricevevano messaggi ed immagini inequivocabili. Tutto senza che i genitori si accorgessero di nulla. Questa è la cronaca, orribile. Ma come è possibile tutto ciò: come è possibile che madri e padri non sospettino e non controllino, per tre anni?
E’ privacy, rispetto della vita privata o colpevole omissione? E dov’è il confine tra l’una e l’altra? La privacy è un diritto e la tutela di questa è una delle sfide della nostra società. Le informazioni che ci riguardano, e dunque le nostre vite, non sono mai state difficili da difendere come oggi con la tecnologia che ha invaso e cambiato le nostre esistenze e le nostre relazioni col prossimo. Ma se la privacy è un valore da difendere anche con più consapevolezza di quanto molti di noi non facciano, è anche un valore assoluto? Oppure ha dei limiti, delle condizioni d’uso e delle eccezioni?
Sembra una domanda capziosa e al limite poco utile. Ma non è così. Come scontata non è la sua risposta. E la cronaca è lì a segnalarcelo con la storia delle tre ragazzine adescate via whatsapp. Stretti tra social network, siti che usano i nostri dati e software di riconoscimento, compreso quello recentemente usato ad Hong Kong e allenato a distinguere gli individui in base al loro modo di camminare, la protezione dei nostri dati, delle nostre informazioni e della nostra privacy non è mai stata messa in discussione come negli ultimi anni. Per la generazioni che ci hanno preceduto il rischio di furto d’identità o anche solo di parte delle informazioni personali e del controllo assoluto era un’opzione quasi scolastica.
Non è più così. Fin da piccolissimi mettiamo letteralmente la nostra vita in mano agli smartphone, e se da adulti rischiamo che ci rubino i dati della carta di credito o del conto in banca, da piccoli rischiamo che ci rubino altro, in primis la fiducia. E’ infatti ormai la norma avere più o meno dai 10 anni di età un telefono con cui comunicare con compagni di scuola e amici, oltre che con i propri genitori. Un oggetto personale con cui si possono fare foto divertenti e rimanere in contatto ma che può anche essere la porta per altro.
E’ il caso della ‘cattivissima Giulia’ e dell’uomo di quasi 50 anni che attraverso le chat ha adescato, irretito e ricattato le tre ragazzine per tre anni. Ma in virtù dei rischi potenziali collegati ad uno strumento che ci consente di comunicare col mondo come uno smartphone, si può considerare quello stesso oggetto più o meno come un diario segreto delle nostre nonne da bambine? Si può in altre parole in nome della privacy o del semplice rispetto della sfera privata non mettere mano e soprattutto occhi in quel telefono? No, non si può. Dal punto di vista in primis etico un genitore non solo ha il diritto, ma soprattutto il dovere di ficcanasare tra le cose dei figli.
Sbirciare le chat del proprio marito o della prima moglie prima che illegale è deplorevole eticamente, ma la questione si capovolge quando il proprietario del telefono è un minorenne. In questo caso non solo il ruolo di educatore del genitore impone un controllo, ma il fatto che il genitore sia responsabile legalmente delle azioni del figlio (almeno sino ai 14 anni) rende l’obbligo tale anche dal punto di vista legale. Nessuno ovviamente vuol gettare la croce addosso ai genitori delle tre vittime dell’orco di whatsapp.
Anche perché come ci insegna l’esperienza non esiste controllo assoluto e non è solo con il controllo che si crescono i figli. I figli si crescono con controllo e fiducia e soprattutto con l’istruzione e l’esempio. Dare un cellulare al proprio figlio ‘decenne’ è forse diseducativo come sostengono molti esperti, ma è anche parte della vita reale. Sbirciarci dentro è un diritto-dovere dei genitori ma l’obbligo primo è quello di parlare con i propri figli, sempre. E insegnargli che come non ci si fida degli sconosciuti che s’incontrano per strada, alla stesso modo non ci si fida degli sconosciuti che s’incontrano in Rete.
di ALESSANDRO CAMILLI