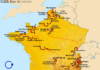Questa è la storia di un asset strategico per l’Italia, l’acciaio, che il Covid ha dequalificato a comparto industriale da riscrivere. Questa è la storia di un effetto domino, di una crisi che ha un capo e una coda, entrambi contaminati, come è contaminata l’intera filiera che li unisce. E, infine, questa è la storia di una filiera in crisi che incrocia altre filiere, altrettanto in crisi, generando un cortocircuito che si traduce in imprese che chiudono, in altre che fanno fatica a riaprire, in fatturati cancellati, in posti di lavoro che ballano, nella cassa integrazione che si è imposta come protocollo del lavoro. La storia parte dall’ex Ilva di Taranto, l’acciaieria più grande d’Europa in mano a Mittal e sempre più in affanno, e arriva fino alle case degli italiani, dove l’acciaio fa capolino sotto forma di un elettrodomestico come il frigorifero piuttosto che un tostapane.
IL CERVELLO DELLA FILIERA È FERMO
Il punto di partenza è quello della produzione. L’impianto pugliese, quindi, dove nasce l’acciaio. Il Covid ha trascinato la produzione ai minimi storici: 7.500 tonnellate al giorno. Gli altoforni accesi sono appena due su cinque, vanno avanti sostanzialmente per tenere in vita l’intero stabilimento. Le commesse non superano le 70mila tonnellate. Numeri irrisori se si considera che la produzione annuale era di 12 milioni di tonnellate prima del sequestro del 2012. Con l’arrivo dei Mittal e le restrizioni per l’area a caldo, la produzione è scesa a 4,5 milioni di tonnellate. Poi è arrivata la crisi del mercato dell’acciaio e la produzione è scesa ulteriormente, a quattro milioni. Il virus è intervenuto su una crisi già in essere e ha acuito i contraccolpi. Con il ritmo attuale, il 2020 si chiuderebbe a 2,5 milioni di tonnellate. Un’ecatombe. Il Covid ha portato l’impianto a girare al minimo e a ricorrere a una massiccia cassa integrazione. Quasi cinquemila lavoratori. La cassa integrazione Covid, quella che è servita come ombrello per tutte le aziende investite dalla pandemia. Ma che succede ora che dal 4 maggio è iniziata la fase 2?
Al netto della decisione di Mittal di restare o meno (ha preso tempo fino al 5 giugno per presentare un piano industriale ma allo stesso tempo valuta di lasciare Taranto), il cervello della filiera non dà segnali di ripresa. La produzione stenta a riprendere. La cassa integrazione, prorogata per altre cinque settimane a partire dal primo giugno, sta lì a significare che il Covid continua a fare male. Lo dice chiaramente l’azienda nel comunicare l’allungamento della cassa integrazione. Si dice "costretta, suo malgrado" alla proroga a causa "della riduzione dell’attività lavorativa riconducibile alla situazione di emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in atto a livello nazionale". Già, la riduzione dell’attività lavorativa. Le misure di distanziamento c’entrano fino a un certo punto. Il danno del Covid, ora, è da rintracciare nelle commesse che non arrivano, nei clienti che disdicono gli ordini, alcuni si sono volatilizzati. Appena lunedì, incontrando i sindacati e il Governo, Lucia Morselli, l’amministratore delegato di Mittal Italia, ha lanciato il grido d’allarme: "Tutti i giorni i nostri clienti ci mandano mail chiedendoci di ritardare di mesi le spedizioni perché non sanno cosa farsene. Non laminiamo perché non vogliono i nostri prodotti, in questo momento spedire per noi è impossibile".
L’INDOTTO E IL SUB-INDOTTO, IL PRIMO MORSO DELLA CRISI
Dentro lo stabilimento ci sono circa 350 aziende. Il numero varia in base al lavoro che macinano gli altoforni, ma costituiscono una parte importante della produzione dell’acciaio. Sono un secondo cervello perché le imprese, che spaziano dalla meccanica alla carpenteria, all’elettrico, si occupano nella stragrande maggioranza dei casi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ex Ilva, oltre che dei lavori di pronto intervento. Queste aziende impiegavano circa quattromila lavoratori. Prima del Covid. Ora sono circa 1.500. La maggior parte, come la gran parte dei 10.700 dipendenti diretti di Mittal, sono in cassa integrazione. Vincenzo Castronuovo è il responsabile dell’indotto per il sindacato Fim-Cisl. Racconta così la situazione attuale: "È un disastro. Ci sono moltissime che avanzano crediti da Mittal per 1,5-2 milioni e questo si ripercuote sui lavoratori. Mittal non paga, noi non possiamo pagare i lavoratori. Alcuni hanno due mesi di stipendio arretrato". Anche quella dei soldi che le imprese dell’indotto non hanno mai ricevuto è una storia che parte da lontano, da quando cioè i commissari presero in mano l’impianto dopo averlo sequestrato ai Riva.
Anche in questo caso il Covid ha aggravato la situazione. La cassa integrazione ha tutelato i lavoratori, ma ora che si può tornare a lavorare, anche qui, come per il cervellone centrale, tutte le aziende stanno ricorrendo a una proroga dell’ammortizzatore sociale. Fare lavori di manutenzione è impossibile. E anche i lavori ambientali sono fermi. Collegato all’indotto c’è il sub-indotto. Sono centinaia di piccole attività che sono sempre ubicate a Taranto, ma fuori dai cancelli dell’ex Ilva. A loro si rivolgono le aziende dell’indotto se devono costruire una scala piuttosto che una passerella o una tubazione. Funzionano come il ferramenta per chi lavora nei cantieri o nei lavori di rifacimento di un appartamento. Un rapporto quotidiano e costante. Nell’effetto domino sono stati trascinati anche loro. Antonio Marinaro, presidente di Confindustria Taranto, ne parla così: "Della crisi che parte dall’ex Ilva ne risentono gli artigiani, i commercianti, tutto il sistema economico locale. La filiera economica è fortemente compromessa. Se non si ha un piano industriale, non si riesce ad avere un’ottica di prospettiva".
L’ACCIAIO FUORI DALLO STABILIMENTO: LA CRISI DEI TRASPORTI
L’acciaio esce dall’ex Ilva sotto forma di enormi rotoli. Una parte finisce negli altri stabilimenti italiani di Mittal, dove viene lavorato ulteriormente per poi rifornire clienti con prodotti specifici. Un’altra raggiunge direttamente i clienti: via mare, attraverso le navi, con la ferrovia o sui camion. Anche qui il Covid ha generato crisi. "La situazione è disperata", racconta Felice Panaro, presidente di Confetra Puglia, la Confederazione dei trasporti e della logistica. "Durante il lockdown non c’erano commesse e poi c’era anche il blocco dei porti. Ora non si capisce se l’Ilva continuerà a esserci o meno". Gli autoarticolati che caricano i rotoloni d’acciaio all’ex Ilva e che sono capaci anche di trasportare i container, viaggiano sempre di meno. Alcuni si sono riadattati, trasportando frutta durante la serrata. Ma il conto è stato nefasto: è andato in fumo il 90% del fatturato. Anche qui il Covid ha aggravato una situazione già difficile, se si considera che il calo dei volumi dai tempi di Riva era stato pari al 45 per cento.
E QUELLA DEL PORTO
Se l’ex Ilva resta ai livelli di produzione attuali, è destinata a scendere sotto al 40 per cento in termini di movimentazioni dentro il porto di Taranto. Quando produceva 8-9 milioni di tonnellate d’acciaio all’anno, la mole di lavoro si traduceva in 35 milioni di movimentazione portuale e in una quota dell′80 per cento. L’Ilva, cioè, era il primo cliente del porto indiscusso. L’impatto sul valore dello stesso porto è imponente: Taranto era il terzo porto in Italia prima del sequestro del 2012, con oltre 40 milioni di tonnellate. Ora, complice il calo della produzione con i Mittal e a causa del Covid, le tonnellate sono crollate sotto i 20 milioni.
AUTO, TUBI E ANCHE GLI ELETTRODOMESTICI: LE DIFFICOLTÀ DELL’ULTIMO ANELLO DELLA CATENA
Come si diceva, una parte dell’acciaio prodotto all’ex Ilva, le cosiddette bramme, va a Genova, a Novi Ligure e negli altri impianti italiani di Mittal per alimentare altre attività industriali. Ma ci sono anche i clienti diretti. Che soffrono, seppure in maniera distinta. Una parte, quella delle aziende che hanno bisogno dell’acciaio per produrre elettrodomestici o tubi, non ricevono il materiale. Di questa crisi ne risentono appunto i tubisti, le carpenterie metalliche e le imprese del settore degli elettrodomestici e delle caldaie. È cioè una crisi da mancata disponibilità di una sorta di materia prima. Sono le aziende che comprano le lamiere o i rotoli dall’ex Ilva per rispondere alla domanda dei piccoli, quella delle microaziende e degli artigiani. Una rete stimata in circa 1.500 commercianti prima del Covid. E questa crisi si ripercuote a sua volta sui consumatori finali, che può essere il cittadino che acquista un frigorifero piuttosto che un altro elettrodomestico prodotto, in parte o in tutto, con l’acciaio.
Poi c’è una larga parte dei clienti, che è rappresentata dai big del settore dell’auto. Ma questo settore è in crisi. E qui ritorna l’allarme dell’amministratore delegato di Mittal, che ha parlato di clienti che disdicono gli ordini. Le case automobilistiche hanno sempre meno bisogno dell’acciaio di Taranto che va a finire in vari pezzi della macchina. Eccolo il cortocircuito: la coda della filiera, scottata dalla crisi del proprio comparto, che contamina il capo della filiera stessa. Un effetto domino trasversale. Filiere in crisi che si incastrano con filiere altrettanto in crisi - L’acciaio serve anche ai cantieri, che sono rimasti chiusi fino al 4 maggio, al netto di quelli strettamente indispensabili. Secondo i dati forniti dall’Ance, a essere riaperti sono ora circa il 75 per cento. Un 20% è in difficoltà e in questa percentuale è compreso chi non riaprirà più. I cantieri scontano il peso della burocrazia e il crollo degli investimenti, ma anche il mancato apporto di acciaio. Vale qui la stessa considerazione che vale per l’auto: le filiere si incastrano. La coda diventa capo e il capo diventa coda.
Giuseppe Colombo