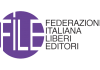di PANTALEONE SERGI
Tiepidi nei confronti del fenomeno mafioso ce ne sono stati da sempre. Come ce ne sono stati timorosi, impauriti, minacciati e, quindi, condizionati. Sia giornali, sia giornalisti. Ma nelle sub-classificazioni possibili, anche in quelle più fantasiose e azzardate, s’è parlato sempre di giornali antimafia ma non s’è mai sentito di un “giornale di mafia” con la stessa funzione che può avere l’organo di una lobby o di un partito in una società democratica. E nella ricca casistica di reati commessi con il mezzo della stampa e con le parole, non s’era mai visto un periodico incriminato, sequestrato e sospeso perché mafioso, un mensile utilizzato da un clan o da suoi membri e sodali per «organizzare e reiterare negli anni una vera e propria campagna di aggressione mediatica», con articoli «intrisi di contenuto calunnioso, falso, allusivo, violento». Con l’obiettivo di colpire la magistratura antimafia. E non solo.
“Il dibattito”:
per la magistratura a Reggio Calabria era un periodico della ‘Ndrangheta
Ha destato scalpore, così, un processo la cui fonte genetica è la dissacrante condotta di un giornale e la conseguente incriminazione del mensile “Il dibattito” che si stampava a Reggio dal 1979, tenendo tanti sulla corda col suo giornalismo aggressivo e il protagonismo strillato del suo direttore già in passato finito nei guai. Non solo per gli attori della vicenda che ha coinvolto due ex deputati (uno era già in galera e l’altro sotto processo per questioni di mafia), ne ha sfiorato altri in carica, ha toccato ambienti istituzionali e deviati, ma anche per la pericolosa evoluzione delle strategie mafiose che il caso evidenzia e addirittura indica come esempio possibile.
I pericoli della mafia finora considerati sono stati ben altri. Per cui, si provi soltanto per un attimo a pensare cosa, nella società dell’informazione, globalizzata, potrebbe significare l’assunzione del controllo dei media da parte delle varie mafie e i rischi a essa connessi. L’industria dell’informazione obbedisce alle regole economiche di mercato e serve anche per fare affari, ma ha in più un potere condizionante ben noto agli oligarchi e ai potenti di tutti i tempi e di tutte le latitudini. Non si creda, allora, a uno scenario da visionari se si pensa come possibile a un mercato editoriale inquinato e, soprattutto, a un giornalismo falsato nella sua essenza di libertà, dalla presenza di giornali e giornalisti al servizio della mafia. Ciò in quanto la forza economica delle mafie del nuovo millennio è tanta e tale da non avere confini. Se la ’Ndrangheta – visto che il caso di cui ci occupiamo è esploso in Calabria – s’è comprata un quartiere di Bruxelles e stava per comprarsi una banca a San Pietroburgo con la quale riciclare i proventi dei vari traffici di droga, perché mai non potrebbe mettere le mani su parte del sistema mediatico per perseguire i propri scopi? Il mondo finanziario non è stato e non è così impermeabile come si vorrebbe. Ma soprattutto in una economia senza confini, le criminalità organizzate italiane, europee ed extraeuropee potrebbero entrare pesantemente nel settore editoriale partendo da nazioni dove i controlli sui capitali sono più labili o esistono vuoti di potere. Basta ricordare, per esempio, come nell’ex Unione Sovietica burocrati ed ex militari abbiano dato una grossa mano ad affaristi dalla dubbia provenienza, offrendo loro servizi e protezioni.
Problemi dell'informazione, gennaio 2005
Se i direttori dicono che la mafia non fa più notizia,
e mafiosi aggiungono che “non deve fare notizia”
In una tavola rotonda su mafia e informazione svoltasi a Palermo nel gennaio del 2004, il procuratore distrettuale antimafia Pietro Grasso, riferendosi alla situazione nel suo distretto giudiziario, ebbe a dire che «la mafia ha tutte le potenzialità per strumentalizzare l’informazione, è in grado di condizionare la stampa per avvisare chi si deve difendere dall’indagine o fare sparire le prove». E subito dopo ha aggiunto: «Forse l’editoria è nelle mani di potentati che non consentono l’indipendenza... Ho sentito direttori di giornali dire che la mafia non fa più notizia (dal punto di vista del mero marketing delle news il ragionamento potrebbe anche non fare una piega, anche se diventa allarmante sotto l’aspetto sociale, nda) e mafiosi che non deve fare notizia. Non è quindi disattenzione ma una precisa strategia dell’organizzazione mafiosa».
Strategia dell’organizzazione mafiosa nel settore della stampa, per i magistrati della Procura antimafia e del Gip di Catanzaro, sarebbe stata quella attuata dal mensile “Il dibattito” che nel mirino aveva come primo obiettivo i magistrati reggini che indagavano sulla mafia. Il giornale li attaccava frontalmente in base all’andamento delle inchieste, dei processi e delle esigenze degli indagati, insisteva per far scattare indagini ministeriali su di loro, ne chiedeva il trasferimento in altra sede, lavorava per creare spaccature tra gli stessi magistrati e per «sfruttare asserite posizioni di incompatibilità ambientale artatamente costruite, per soddisfare fini propri dei correi».
A Reggio Calabria un verminaio,
con “Il dibattito” a tessere le fila
Un affare serio. Un verminaio. Con Francesco Gangemi, giornalista pubblicista, già sindaco di Reggio Calabria per tre settimane dopo la scoperta della tengentopoli reggina nel 1992, che porta avanti, con il suo mensile “Il dibattito” ben diffuso anche nelle carceri, una martellante campagna di stampa (e di calunnie secondo l’accusa), contro il prefetto («Ostacola e osteggia il prefetto Goffredo Sottile», scrivono i magistrati catanzaresi), contro la Curia con accuse di pedofilia, e soprattutto contro magistrati inquirenti come Vincenzo Macrì il quale fece arrestare l’ex deputato socialdemocratico Paolo Romeo, mafioso, ora in carcere per una condanna definitiva, ispiratore de “Il dibattito”, Alberto Cisterna, Roberto Pennisi, Giuseppe Verzera, Salvatore Boemi e Francesco Mollace (quest’ultimo ha fatto arrestare il boss Orazio De Stefano), nonché i presidenti dell’Assise Franco Greco che condannò Romeo, e Silvana Grasso che ha giudicato le malefatte del clan De Stefano. Le intercettazioni, in un cui si ascoltano anche voci e chiacchiere malevole di faccendieri, giornalisti, monsignori e mafiosi, dimostrano che il direttore de “Il dibattito”, cugino dell’omonimo compare d’anello di Raffaele Cutolo, anche lui coinvolto nell’inchiesta, aveva a sua volta un suggeritore nell’ex parlamentare Romeo, una sorta di direttore occulto del mensile, il quale, nel gennaio 2003, al telefono si esprimeva così: «Dobbiamo distruggere questi magistrati».
9 novembre 2004. Le motivazioni del
sequestro: “Il dibattito” è “corpo di reato”
L’Ansa diffonde la notizia nelle prime ore del 9 novembre 2004. «La Procura distrettuale di Catanzaro ha disposto il sequestro del periodico “Il dibattito”, edito a Reggio Calabria e diretto dal giornalista Francesco Gangemi». In effetti, il sequestro è un tassello di un provvedimento giudiziario molto più vasto e pesante. Il Gip del Tribunale di Catanzaro Antonio Baudi, su richiesta della procura antimafia, dispone l’arresto di sei persone con l’accusa di «associazione di tipo mafioso finalizzata ad esercitare, per il tramite del periodico “Il dibattito”, violenza e minaccia nei confronti dei magistrati del distretto di Reggio Calabria allo scopo di turbarne o impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l’attività».
L’indagine di per sé è clamorosa perché mette in luce un sinistro scenario in cui mafia e politica vanno a braccetto. Ma lo è ancor di più in quanto con la stessa ordinanza il magistrato dispone il sequestro preventivo del mensile, e ciò perché «l’attività criminosa è stata reiteratamente perpetrata dagli indagati grazie al determinante contributo del periodico “Il dibattito”, autentico corpo di reato». Forse per la prima volta un giornale viene sequestrato come “corpo di reato” e di un reato così grave e allarmante come quello mafioso. Il sequestro viene effettuato con il dichiarato intento di impedirne la pubblicazione: «Si rende assolutamente necessario procedere al sequestro preventivo di tutti i beni pertinenti alla pubblicazione la cui liberalità – spiega il magistrato – è fonte di pericolo reale e per evitare che i reati, in particolare quelli indicati al capo b (e cioè l’aggressione ai magistrati per condizionarne l’attività, nda) ed ascritti in continuazione criminosa, possano essere portati ad ulteriori conseguenze, reiterarsi e proseguire inarrestabilmente nel tempo».
La campagna mediatica sostengono, insomma, gli inquirenti, è durata anni anni, è stata devastante e deve finire. Per evitare che si andasse avanti il magistrato, così, sequestra il «fascicolo di autorizzazione per la pubblicazione, n. 10 del 12 novembre 1979, esistente presso il Tribunale concedente, di Reggio Calabria», nonché «gli strumenti utilizzati per la pubblicazione presso la sede redazionale». Ci avevano provato a farlo sequestrare. Ci aveva provato, per esempio, Eduardo Lamberti Castronovo, medico, editore di una tv privata, Rtv, quando s’era visto accusare di essere un ladro. Ebbe un incontro con Gangemi. «Mi chiese 10 milioni di euro. Il prezzo per cessare la campagna contro di me», ha raccontato Lamberti Castronovo denunciando l’episodio. In tanti, pilatescamente, se ne lavarono le mani. Il procuratore di Reggio Antonino Catanese, spiegò al medico-editore: «Dottore, capisco il suo disappunto, ma io non posso sequestrare quel giornale, perché in Italia c’è la libertà di stampa. E fino a quando non si ravvisano reati contro la pubblica morale o si paventano sommosse...». L’ha sequestrato, invece, la Procura di Catanzaro, con soddisfazione di quanti, in questi anni, sono stati “vittime” delle attenzioni del giornale.
Tace l’Ordine, tace il sindacato, i giornalisti reggini
non sanno che dire dopo anni d’intimidazioni
Tace l’Ordine dei giornalisti, tace il loro sindacato, c’è imbarazzo nel giornalismo reggino tirato per la giacchetta nell’inchiesta, visto che nelle pagine dell’istruttoria – soprattutto nelle lunghe informative della polizia e nella massa di intercettazioni – circolano diversi nomi di giornalisti a volte protagonisti, altre volte “vittime” delle pungenti ironie o critiche attenzioni di alcuni degli inquisiti.
E’ il giornale – indicato come organo della mafia – al centro delle attenzioni della magistratura. Il giornale, nella sua continuità, numero dopo numero, come strumento dell’agire mafioso. Il direttore Gangemi era già finito in carcere nel 2001 e si poteva anche credere che la “linea editoriale” fosse una conseguente reazione. «Le copie del periodico, se lette isolatamente, possono erroneamente fornire l’idea di un attacco isolato, pianificato all’indomani dell’arresto del Gangemi sulla base, forse, di un’onda emotiva». Invece no. «La lettura delle pubblicazioni precedenti – è scritto nell'ordinanza – unite a quelle del periodo successivo, invece, rende un quadro maggiormente allarmante». C’è un disegno (con la «copertura derivante dalla forza intimidatrice propria del vincolo associativo», come spiega il Gip) che vede tra gli attori principali anche i politici inquisiti che non assumono certo il ruolo di fonti avide o compulsive, che danno informazioni interessate e fanno indebite e pesanti pressioni per vedersele pubblicate, bensì sono essi stessi compartecipi della linea editoriale e dei contenuti del giornale che in questo modo diventa canale- postino di messaggi. A Reggio, oltretutto, non rappresenta un inedito il fatto che un potente indagato si serva di un giornale per attaccare i magistrati. In altra occasione Amedeo Matacena, ex parlamentare forzista coinvolto anche in questa vicenda, avrebbe utilizzato allo scopo un altro settimanale amico. A testimoniarlo c’è un suo uomo di fiducia, Giuseppe Aquila, componente del casato mafioso dei Rosmini, ex “ragazzo di camera” sulle navi traghetto, carriera politica fulminante ma stroncata da una maxinchiesta sulle cosche, legatissimo a Matacena: «Per attaccare i Magistrati Amedeo Matacena si è servito del settimanale “Tribuna Calabria”, al quale inviava i documenti da pubblicare direttamente dal fax della sua segreteria. Ho direttamente assistito all’invio dei documenti che il Matacena consegnava, dopo averli confezionati, alla sua segretaria. Devo precisare che, il materiale, veniva inviato a tutti i giornali, ma non da tutti veniva pubblicato. Quando parlo di documenti intendo riferirmi non solo a comunicati stampa da lui preparati, ma anche ad atti ufficiali, tipo estratti o parti di sentenza e dichiarazioni di collaboratori, o altri atti processuali». Allo stesso modo Matacena, secondo i magistrati inquirenrti, s’è servito de “Il dibattito” al quale «inviava i comunicati stampa che preparava e la documentazione di cui entrava in possesso per screditare i Magistrati». Afferma, a tale proposito, il pentito Paolo Iannò: «Buttava fango, fu lui (Matacena, nda) che istigò a buttare fango sulla Grasso e su Greco, perché si vide coimputato anche lui...»,.
Le tecniche “professionali” del periodico di Francesco Gangemi:
la mafia è quella che indaga contro i clan
Cosa fa “Il dibattito” lo abbiamo visto. Cerchiamo di vedere e di capire adesso come lo fa, seguendo il ragionamento dell’accusa, ma non solo. Intanto il giornale sembra ossessionato dal lavoro della Procura distrettuale antimafia e dei processi che ne scaturiscono specialmente se questi processi riguardano i due politici che lo ispirano. «Strumento intelligente, capace di adeguarsi ad ogni situazione contingente ed in grado di mutare forma al mutare delle situazioni», il mensile di Gangemi attinge a piene mani agli atti giudiziari anche segreti (gli sono stati sequestrati persino ordini di cattura in originale mai eseguiti) per rintuzzare sul nascere le accuse screditando chi le fa. Privo di tecnica professionale, ricco di omissioni e di adattamenti, se vogliamo incasellarlo in una nomenclatura possibile si avvicina molto al giornale politico e usa quasi sempre un linguaggio “poco giornalistico”, il linguaggio del libello, del comizio, dell’arringa. L’invettiva diventa modello di scrittura. I toni aspri, le frasi taglienti come lame superaffilate, senza sfumature nei giudizi, però, non sono riservati alla ’Ndrangheta, ai suoi uomini e alla loro nefasta presenza a Reggio e in Calabria, bensì a chi lavora per accertarne le responsabilità. Un atteggiamento, questo, che non trova alcun riscontro nella storia del giornalismo italiano in cui pure il fenomeno mafioso ha goduto a lungo di una sostanziale disattenzione, quando giornali e giornalisti non avevano percepito la complessità del fenomeno e la raccontavano male e in maniera frammentata e occasionale. Solo negli ultimi venti anni (in seguito ad alcuni avvenimenti di mafia di grande impatto “mediatico” che hanno sconvolto al coscienza civile del Paese, come la strage di via Carini a Palermo, considerata il media-event che ha acceso i riflettori della stampa sulla mafia) il problema della rappresentazione sociale della criminalità organizzata ha trovato la necessaria attenzione, pur nella convinzione che l’informazione, fondamentale risorsa cognitiva, non ha certamente il compito di sconfiggere la mafia ma deve soltanto “informare” correttamente per lottare contro essa.
Nella rappresentazione mediatica che “Il dibattito” fa della mafia, appresa la lezione secondo cui la realtà è quella che appare e non quella che è (in qualsiasi fenomeno sociale, infatti, una componente essenziale consiste nella percezione che si ha di esso), c’è un evidente rovesciamento delle parti e dei ruoli e introduce un terzo momento, rispetto a quelli della disattenzione e dell’attenzione generalmente considerati: quello dell’antimafia rovesciata. L’interesse del periodico per gli argomenti trattati non dipende dalle regole di notiziabilità e di rilevanza informativa bensì dalla necessità di convincere l’opinione pubblica che la mafia c’è ma è quella esercitata da chi indaga contro i clan. Serge Moscovici (Le concept des rappresentations sociales), d’altro canto sostiene che «lo scopo di tutte le rappresentazioni sociali è quello di rendere qualcosa d’inconsueto, o l’ignoto stesso, familiare». “Il dibattito”, dunque, si mostra impegnato, proponendo un proprio modello d’interpretazione della realtà, a rendere normale l’anormalità della presenza mafiosa e anormale la normalità della giustizia.
Titoli e articoli, allora, non sono dedicati ai pericoli e allo strapotere dei cartelli mafiosi radicati sul territorio e ai loro rapporti con la politica e alla prospettiva di una massiccia espansione dell’economia “sporca”, ma ai magistrati, indicati come veri boss e ’ndranghetisti, e alle loro inchieste indirizzate, per il giornale, a far vincere la vera mafia, quella delle toghe. Si persegue così, in base all’accusa, la delegittimazione della magistratura del distretto giudiziario di Reggio Calabria, una delegittimazione «mirante ad indebolire Autorità giudiziaria e Forze dell’Ordine, nel chiaro disegno di attentare alle Istituzioni attraverso la stampa».
Settantasette pagine su centocinquanta dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip di Catanzaro Antonio Baudi, spiegano il ruolo del mensile considerato, quindi, al servizio della ’Ndrangheta; tutto il secondo capitolo del primo volume dell’inchiesta, oltre settecento pagine, è dedicato alla ricostruzione, mediante intercettazioni, testimonianze e riscontri documentali, della parte pesante che il giornale ha svolto – parte ben nota nelle carceri – nella delegittimazione dei magistrati antimafia. “Il dibattito” – dicono i giudici inquirenti – è stato lo strumento principale di aggressione. Attraverso il giornale, insomma, si è tentato di far passare chi indagava sulla mafia come partecipe di un “patto scellerato” contro i politici reggini indagati e processati per mafia, allo scopo di screditarlo e di creare “disarmonie” nel nucleo storico dell’antimafia. Il giornale è stato utilizzato così, trasformando la sua funzione, in un mezzo di pressione e di formazione dell’opinione pubblica nel tentativo ultimo di difendere Paolo Romeo e Amedeo Matacena nella vicenda giudiziaria che li vedeva e li vede ancora coinvolti.
Per farsi un’idea: campionario di titoli
e articoli contro la magistratura anti mafia
Ora non è detto che un giornale non possa denunciare e non abbia denunciato errori e reati commessi da magistrati, chiedendone e a volte ottenendone il loro allontanamento da un’inchiesta, dalla città e dalla stessa magistratura. Tra i compiti di un giornalismo “cane da guardia” c’è anche questo: vigilare sulla correttezza delle istituzioni. Ma tale compito deve essere svolto nell’interesse generale della giustizia e quindi delle libertà dei lettori e dei cittadini, senza altri fini. E soprattutto deve essere condotto nel rispetto della verità sostanziale dei fatti. Non sembra il caso de “Il dibattito” e dei magistrati di Reggio Calabria messi sott’accusa. Qualche esempio, tra i più espliciti, nel linguaggio e nei contenuti, in un piccolo florilegio di titoli e testi abbondanti di maiuscole, meglio di qualunque cosa può servire a far capire come realmente “Il dibattito” operasse.
Marzo 2000: «Tribunale di Reggio: una storia che parte da lontano». In prima pagina, accanto alla foto del giudice Vincenzo Macrì e il rinvio a un articolo che occupa le pagine 11, 12 e 13 in cui si parla del procedimento disciplinare davanti al Csm contro il magistrato». Sempre a pagina 13: «Matacena accusa», un articolo in cui si dice che il parlamentare vuole sapere se sia stato avviato un procedimento per falso materiale e ideologico contro Macrì «paladino della sottocasta comunista all’interno della magistratura».
Aprile 2000: «Ricomincio da due». Ancora contro il dottor Macrì. E ancora: «L’impostore Gangemi: Gangemi è pregiudicato calunniatore ed estortore. Operazione floppy disk», in cui si commenta l’indagine della procura contro lo stesso direttore del giornale, accusato di estorsione.
Maggio 2000: in prima pagina si legge il titolo «L’insabbiatore – Reggio Roma, rifiuti radioattivi e traffico d’armi». L’articolo, pubblicato alle pagine 2, 3 e 4, sulla falsariga dei numeri precedenti contiene accuse al dottor Alberto Cisterna, “reo” di avere insabbiato l’indagine già coordinata dal P.M. Guido Neri. Si legge, tra l’altro, «Lei Dr. Cisterna è proprio l’insabbiatore di un processo che avrebbe potuto portare dietro le sbarre gli attentatori dell’umanità». E ancora: «I coniugi Grasso e greco. Non sono stati sufficienti 30 parlamentari per indurre l’ex ministro Diliberto a rimuovere una situazione ambientale ai limiti della tolleranza. La presidente Grasso, moglie del giudice Greco che esercita le sue funzioni nello stesso distretto giudiziario, è esecutato per debiti nei confronti di molti istituti di credito, da Giudice del Tribunale di Reggio...».
Ottobre-Novembre 2000: viene condannato Paolo Romeo «Vittima della strategia della tensione giudiziaria» e non mancano i riferimenti ai debito dei giudici Greco e Grasso. Dicembre 2000: «Una toga abusata e il delirio di onnipotenza», contro il dottor Macrì, un «cocktail di collaboratori compiacenti e di inquirenti avidi di conferme ai loro teoremi» che hanno reso possibile la condanna di Romeo.
Febbraio 2001: «Macrì... l’etica nella polvere». «Le “dritte” di Macrì ai “dritti” Lauro e Barreca». «Il fantasmacrì e il suo prodotto mezzo politico e mezzo corrotto». «Macrì: travaso biliare in toga, l’uomo quando dissente odia».
Settembre 2001: «Il patto scellerato tra magistratura, politica, massoneria, mafia e ’ndrangheta – procuratore Boemi è ora di consuntivi». Nel testo: «Lei Dott. Boemi dal 1993 cavalca l’onda lunga del crimine organizzato nella trincea più avanzata. Sono trascorsi oltre otto anni e lei dott. Boemi se ne dovrebbe andare via assieme ai suoi validissimi collaboratori». E ancora nel corso dell’articolo: «Soltanto due deputati della Repubblica sono stati condannati, rispettivamente dalla sposa del presidente Greco, dottoressa Grasso: Amedeo Matacena. L’altro, dallo sposo Greco: Paolo Romeo. Colpiti entrambi (gli unici) sulla base di una trama giudiziaria».
Febbraio 2002: In prima pagina è titolato: «Giustizia stracciata. Anno 1994. Il patto scellerato tra magistrati calabresi (delinquenti e utili idioti) e messinesi. Regista Macrì arrestano Foti e poi tentano con due perizie false di incastrare il PG Neri. Obiettivo finale i Giudici Viola Pontorieri e Montera. Nel centro del mirino il coraggioso Avvocato Colonna. Effettuate due perquisizioni presso la DDA di Reggio. Il Procuratore Catanese alla vista dei Carabinieri è colto da malore».
Marzo 2002: «Giustiziopoli. La guerra tra bande di magistrati delinquenti», «Mollace il cerimoniere corrotto e il patto scellerato».
Aprile 2002: «Gli stracci della giustizia – quali i veri interessi che legano boss mafiosi di Reggio e Sicilia?» Nell’articolo si legge ancora: «La collusione del Pm Mollace con elementi della ’ndrangheta e carabinieri al soldo della distrettuale».
Maggio 2002: «Giustizia selvaggia».
Giugno 2002: «Mala Giustizia. L’onorevole Napoli al Ministro di Grazia e Giustizia: Quei magistrati sono corrotti». E ancora: «La viltà di Boemi»; «Il PNA Cisterna abbandona moglie e figli e convola col suo uditore giudiziario incinta».
Luglio 2002: «Giustizia infedele».
Settembre 2002 (edizione straordinaria): «In una parola Mollace ha aiutato la mafia tramite il suo ufficio». E ancora: «Giustizia di Cosa loro».
Ottobre 2002: «’Ndranghetista sono io o il boss Francesco Mollace?»
Gennaio-Febbraio 2003: «Don Ciccio Mollace e il plastificato Lembo sono i referenti di Cosa Nostra».
Aprile 2003: «Il capo ’ndrangheta di Casignana don Ciccio Mollace».
Aprile-Maggio 2003: «Angela Napoli al ministro Castelli: tolga dalla Procura quel mafioso di Mollace»; «Il dominus dei tribunali è il boss mafioso Francesco Mollace».
Settembre 2003: «Depone il mafioso Mollace».
Ottobre-Novembre 2003: «Il califfo mafioso Mollace».
Quando un giornale è “organo di mafia”
Sono titoli e testi così eloquenti che dispensano da qualsiasi tipo di analisi. “Il dibattito” ha, in pratica, ribaltato la prospettiva di lettura del fenomeno mafioso e della sua rappresentazione con una serie di accuse e attacchi gratuiti, formalmente – per i lettori medio bassi – frutto di una sorta di giornalismo investigativo che, come abbiamo visto, era però tutt’altro. Non più l’attenzione sulle cosche, sui loro affari, sulle loro strategie violente, bensì la messa alla gogna di un’intera istituzione antimafia accusata essa di comportamenti mafiosi e di operare con metodi e con obiettivi tali da favorire la mafia piuttosto che combatterla. E ciò è stato fatto con una terminologia (oltre che con argomenti) che nulla hanno a che vedere con il giornalismo – né tanto meno con il giornalismo d’inchiesta che ha pagato prezzi enormi in termini di vite umane, in Sicilia soprattutto e in Campania – a cui gli autori, il direttore e i suoi suggeritori pensavano di ispirarsi. Per gli inquirenti si manifestava in questo modo soltanto una «strategia d’attacco ai magistrati da tempo pianificata e diretta dall’avvocato Paolo Romeo»
Al di là di quelle che sono le posizioni personali degli indagati, alcune già diversamente configurate dallo stesso Gip e dal Tribunale del Riesame, e dei profili penali di un’accusa così pesante che, comunque, avranno bisogno di essere valutati in tutti i gradi di giudizio, di per sé l’etichetta di “organo della mafia” attribuita a un giornale, impone una seria e profonda riflessione. Essa deve necessariamente coinvolgere i giornalisti, gli studiosi e le istituzioni, non solo, anche se per prime, quelle di categoria. Queste ultime, infatti, in una città come Reggio e in una regione come la Calabria già cariche di difficoltà e in cui è problematico svolgere in libertà la stessa attività di giornalista per le dogane politiche imposte a un’editoria locale molto debole, sono stati quantomeno colpevolmente disattenti su quello che stava avvenendo.
PANTALEONE SERGI
Giornalista, scrittore