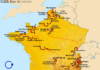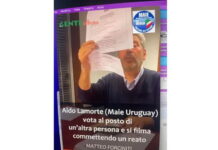di Alessandro De Angelis
Partiamo da quel che non c'è. Da un lato l'autocritica, in questo centrodestra alla Catalano, che si limita a dire "colpa della divisioni". Eh Certo, "meglio uniti che divisi", vale sempre, come se l'unità fosse una disciplina comportamentale e non una costruzione politica (e magari anche culturale). La sindrome del precipizio da leadership declinante per il leader della Lega, la sindrome dell'alta quota per la leader di Fdi: paralizzati dalla tenzone sulla leadership che si consuma sul terreno del governo Draghi, l'uno preoccupato della vittoria dell'altro, hanno innescato una spirale da gioco a perdere, di cui fa parte la leggerezza nella selezione della classe dirigente e il disimpegno nella risoluzione di beghe da strapaese da Verona a Catanzaro.
Dall'altro l'analisi, e anche la scaramanzia perché proiettare sulle politiche i test delle amministrative non ha portato mai tanto bene al centrosinistra, neanche ai tempi di Rutelli e Bassolino (con tutto il rispetto vittorie dal peso imparagonabile con l'oggi) quando poi la "gioiosa macchina da guerra" si arrese alla novità di Berlusconi oppure alle regionali del 2005 che diventarono un pareggio nel 2016. Se c'è un "campo largo" vincente nel "campo stretto" del paese che ha votato, esso tra l'altro non è più specchio di quello parlamentare, anzi l'indicazione delle urne ne indica il suo superamento: l'idea cioè di non appaltare il rapporto col popolo a chi, come i Cinque stelle, non lo rappresenta più ma di conquistarlo con una proposta seria e col civismo. Insomma, la "macchina" è tutta da costruire e non basta l'inerzia se, tanto per dirne una, Calenda, decisivo ad Alessandria, si è affrettato a dichiarare, ancora una volta, "alle politiche vado sa solo". E lì – piccolo dettaglio - non c'è il doppio turno.
Diciamola così: il primo turno ha certificato la crisi strutturale del grillismo, il secondo della Lega, che ha perso l'egemonia nel Nord, nella coalizione e la sua capacità di mobilitare il suo elettorato. Con questa doppia sconfitta si chiude il ciclo aperto con la doppia vittoria dei populismi targati 2018, ma non se ne apre uno nuovo, anzi. Anche perché non c'è un fil rouge nazionale che spieghi il tutto, ma risultati che si spiegano con questioni, errori, personalismi piccoli piccoli spesso legati a questioni locali. Insomma, il vecchio muore e il nuovo non nasce (almeno per ora) e nell'interregno si verificano i fenomeni più morbosi, diceva Gramsci. In questa transizione, segnata dall'assenza di una iniziativa, Conte ha provato a rispondere alla botta irrigidendosi sul governo e si è beccato una scissione, ritrovandosi in una terra di nessuno (né compiutamente di governo né compiutamente di lotta).
Non ci sarà nessun 25 luglio, per assenza di frontman in grado di sfidarlo, e perché il leader della Lega ha ancora il potere di fare le liste, potere che ha anche Conte e infatti la scissione si è consumata anche sul tema dei mandati. Ci sarà il tentativo di costruire un recupero sul terreno del logoramento del governo sulla base dell'assunto, tanto scontato quanto opinabile, che chi sta fuori (Meloni) cresce, il che è destinato ad acuire la crisi, non a diminuirla.
La migliore analisi, paradossalmente ma non troppo, l'ha fatta Draghi già prima del voto parlando di un rischio populismo come conseguenza della crisi energetica ed economica, in questo complicato tornante della storia. E se è chiaro quale sia quello visibile – il "tanto peggio per gli altri, tanto meglio per me" di Giorgia Meloni funziona in un'epoca in cui ognuno pensa al suo particulare più che a una proposta per il paese – è soprattutto su quello invisibile che si giocherà la partita delle politiche. C'è un tema di Italia profonda, la vera maggioranza (per ora silenziosa) che non va a votare, segnata dalla disaffezione. È un sentimento dentro il quale ci sono tanti possibili sviluppi della crisi italiana: rabbia sopita, rivolta alla ricerca di forme di espressione, secessione più o meno stabile tra popolo e sistema politico, potenziale fascinazione verso vecchi e nuovi pifferai magici e proposte estemporanee. Il populismo è ancora vivo e lotterà insieme a noi, si tratta di vedere con quali interpreti, vecchi e nuovi, del suo campo largo. E quale è l'alternativa in grado di affascinare la disaffezione sulla proposta.