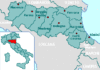PORTOFRANCO
DI FRANCO MANZITTI
Quasi allo scadere del quarto anniversario della tragedia civile dei 43 morti, del ponte crollato, della città spezzata in due, del sistema infrastrutturale nord italiano e europeo in crisi, il processo è finalmente cominciato. Una udienza numero uno all'inizio di questo luglio italiano infuocato. Come un lampo prima del rinvio ai primi di settembre, quando le udienze saranno tre alla settimana incessantemente per un anno.
Il presidente del Tribunale di Genova ha annunciato che il processo per fare giustizia non finirà prima del 2024. Cinquantanove imputati, seicento parti civili, una montagna di perizie, centinaia di testimoni per decidere se ci sono dei colpevoli, quanti sono, quale reato hanno commesso, disastro colposo, strage colposa, omicidio colposo, attentato al sistema dei trasporti. Per decidere quale pena comminare.
Per celebrarlo, questo processo-monstre, forse il più complesso della storia italiana per difficoltà di materie, prove e controprove raccolte anche con i nuovi sistemi tecnologici informatici, tecnicalità di perizie su un ponte crollato, lungo un chilometro e cento metri, quattro stralli alti più di cento metri, sono state attrezzate tre aule collegate informaticamente una all'altra, dislocate in punti diversi del palazzo di Giustizia genovese, l'ex Ospedale, di costruzione quasi medioevale, trasformato nel Novecento in aule di giustizia.
La dimensione giudiziaria fa sparire qualsiasi precedente e impallidire anche i maxi processi per mafia e per terrorismo che magari avevano anche maggior numero di imputati, ma minore articolazioni di giudizio, sicuramente meno testimoni, meno perizie, infinitamente meno parti civili.
Forse poteva essere un processo simile a questo quello per la tragedia del Vajont, un evento paragonabile, almeno per il criterio della possibile prevedibilità.
Lì un pezzo di monte che cade in un invaso, fa tracimare oltre la diga una montagna di acqua e “annega” migliaia di vite, paesi interi. Qua un ponte autostradale, uno dei più trafficati d'Italia, 10 mila automezzi al giorno e sotto Genova con le sue case, le strade, le fabbriche, che si spezza di colpo nel cuore urbano della sesta città italiana
Nella prima udienza-lampo si sono espletate le procedure di inizio processo , adempiendo alla incardinazione del processo.
Da settembre si incomincerà a entrare nel merito, davanti a una platea di avvocati difensori, di parte civile, di periti, di esperti, attendendo il fiume delle deposizioni, a incominciare da quei 59 rinviati a giudizio.
Ma intanto già ci sono intuibili linee di difesa e polemiche molto dure, che incominciano proprio da quella della trasparenza del processo, nel quale le telecamere saranno ammesse solo a inizio udienza e non potranno documentare tutto il resto.
La frase del difensore del principale imputato al processo, che ha spiegato sbrigativamente il crollo con l'ipotesi del “difetto strutturale di costruzione”, è, per esempio, diventata di fatto un capo di imputazione totalizzante o quasi l'anticipo di una sentenza di condanna totale.
Il Morandi è crollato perchè aveva in sé l'errore di quel cemento precompresso con la struttura di acciaio inesorabilmente destinata a deteriorarsi nell'anima della gigantesca struttura?
Se così fosse allora vuol dire che per i brevissimi 51 anni della sua vita il grande ponte è stato lasciato a marcire con la corrosione che avanzava nella sua anima moderna, inventata da Riccardo Morandi, l'archistar di allora, che aveva firmato il progetto, mai collaudato in quel nuovo metodo e sopratutto mai controllato. Come lo stesso architetto aveva richiesto insistentemente fino al giorno della sua morte nel 1989 con lettere drammatiche: “Controllate il cemento precompresso, l'acciaio che sta dentro.....”
Dovevano controllare lo Stato, responsabile pubblico della sicurezza in un primo periodo, e poi i privati concessionari che dall'inizio degli anni Novanta lo hanno gestito con il compito di , mantenere, ammodernare, controllare sopratutto la sicurezza.
Questa tesi, sparata all'inizio di un processo che andrà avanti per almeno due anni e culminerà in una sentenza a sei anni, almeno, dalla tragedia e in primo grado soltanto, che per l'appello e la Cassazione ce ne vorranno almeno altri cinque-sei, fa capire come anche davanti alla più grande tragedia civile, appunto dopo quella del Vajont, i tempi della giustizia non escono dal binario della loro inesorabile lentezza.
E poi fa capire quale sarà il nocciolo della difesa da parte dell'imputato principale, l'ultimo amministratore della concessionaria, Giovanni Castellucci.
Era un ponte condannato a morte da quando era stato costruito. Che ci potevamo fare? Quel ponte era una specie di condannato a morte. Chi lo ha gestito, pubblico e poi privato che fosse, ha semplicemente rallentato un processo destinato a compiersi con l'atto finale: il crollo tra la pila nove e la pila dieci, i 250 metri che si spaccano come un grissino sotto il nubifragio del 14 agosto 2018.
Sui tempi della giustizia si possono scrivere trattati infiniti e rievocare esempi italiani che ricordano grandi processi storici diversi e simili a questo. Dalla strage di piazza Fontana, ancora in ballo 57 anni dopo, a quello dello strage ferroviaria di Viareggio appena giunto al verdetto della Cassazione, 13 anni dopo.
Insopportabile questo spazio di tempo che allontana, anno dopo anno, dal momento tragico, anche dopo il lavoro eccezionalmente veloce, efficiente e sopratutto trasparente compiuto dalla Procura di Genova, condotta da Francesco Cozzi fino a un anno fa esatto e ora retta provvisoriamente da Francesco Pinto.
Certo, le probabili seicento parti civili in causa, la complessità delle perizie e tante altre difficoltà sono una ragione dei tempi, ma non fanno accettare la distanza tra la tragedia, il dolore immane, i danni incalcolabili e l'esercizio della giustizia.
Poi c'è il problema della trasparenza, che davanti a nessun processo come per questo era fondamentale.
Il processo Morandi, facendo le dovute proporzioni, è la Norimberga dei crimini sulla sicurezza pubblica. Riguarda ogni viaggiatore autostradale, e non solo, affidato a un concessionario, al contratto tra lo Stato e chi gestisce un bene usato da tutti.
Quella tragedia delle 11,36 del 14 agosto 2018 ha spezzato il rapporto tra chi si affida e chi gestisce. Capire, assistendo al processo, perchè e per come è successo e chi ha sbagliato è un diritto di tutti.
Negarlo o limitarlo, o ridurlo, con la ragione della spettacolarizzazione e delle difficoltà logistiche, è una violazione intollerabile.
In altri paesi più civili socialmente e giuridicamente del nostro avrebbero costruito un'aula apposta per celebrare questo processo in modo conforme a quella necessità di pubblicità.
Quel dolore, che non si spegne, urla la volontà di sapere tutto, di vedere tutto, di assistere al momento nel quale gli imputati rispondono alle domande che ognuno si pone da quel momento. Lo si chiede non solo per chi è morto, “colpevole” di essere lì in quel momento, in quel minuto, non un secondo prima, né un secondo dopo, ma per tutti.
Basta continuare a viaggiare per le autostrade liguri ( e non solo) di oggi, quasi quattro anni dopo, nello sfacelo dei cantieri che non finiscono mai, per capire quanto grande sia la responsabilità a monte, di chi ha costruito, magari con un difetto strutturale, ma soprattutto di chi non ha controllato, verificato, rispettato il patto che garantisce non solo il pedaggio da pagare, ma la vita di chi viaggia. Si viaggiava a proprio rischio e pericolo senza saperlo, affidati al caso, al destino personale, a infinitesimali coincidenze. Un processo degno deve stabilire chi ha sbagliato, quanti hanno sbagliato.